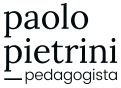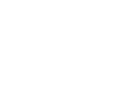L'illusione della scienza senza limiti
Accettare che l’umano abbia una parte misteriosa, insondabile, inaccessibile alla comprensione aprirebbe a un più facile accesso al farne esperienza, e ci aiuterebbe ad abbandonare l’illusione che dell’umano si possa capire tutto.
In questo senso, l’approccio scientifico non dovrebbe diventare, come mi pare qualcuno ogni tanto stia auspicando, l’unico valido punto di riferimento per l’umano.
Qundo sento “E’ la scienza che lo dice” la mia soglia dell’attenzione si alza.
La scienza, per definizione, si orienta alla certezza. Per questo, in una disciplina come la conoscenza dell’umano, che sguazza nell’incertezza, anche i grandi scienziati hanno sempre fatto riferimento alla letteratura, alla filosofia, all’arte.
Oggi, per merito della scienza, si può dire che ciò che succede dentro di noi nel guardare, per esempio, “I girasoli” di Van Gogh derivi dall’effetto che la restituzione della sola luce gialla da parte del pigmento utilizzato, che trattiene tutti i colori tranne il giallo, ha l’effetto di scaricare il potenziale di azione dei neuroni colpiti attraverso l’apparato visivo da quella luce gialla, che in conseguenza a ciò attivano il circuito della ricompensa rilasciano dopamina a livello cerebrale.
Così sappiamo che “I girasoli” ci piace.
Ma come si spiega che “I girasoli” non piace a tutti nello stesso modo, che addirittura a qualcuno non piace?
E che a una stessa persona, una cosa prima piace e poi non piace più? O piace in un modo diverso?
Per questo ci dobbiamo affidare alle discipline descrittive, più che a quelle normative.
Che non spiegano ma raccontano, che non predicono ma dicono quello che succede.
L’uomo che racconta dell’uomo, che pensa sull’uomo, che si fa una sua opinione dell’uomo. Con le sole sue qualità umane, anche con il solo suo intuito. L’idea che capire tutto si può, che corrisponde poi all’idea che controllare completamente la realta si può, dovrebbe essere relativizzata, de-assolutizzata, ridimensionata.
Intendiamoci, gli scienziati devono continuare a fare il loro lavoro, generando quella conoscenza certa che guida l’evoluzione, ma per esplorare l’umanità e la vita dell’umano non in senso lungo ma in senso largo – come ci suggerisce Recalcati- focalizzandoci su ciò che qualifica come tale un essere umano, che lo distingue da altri esseri viventi, la scienza presa a guida assoluta potrebbe essere fuorviante, soprattutto rischia di creare il grande equivoco che questo possa aiutare le persone nella loro vita quotidiana. Così la gente comune che si affida alla scienza potrebbe credere che la scienza stessa possa aiutarla a gestire la sua giornata. Questa, a mio modo di vedere, è una rischiosa illusione. Si impara a gestire una giornata, vivendola accettando i rischi annessi e connessi di non sapere esattamente cosa succederà, piuttosto che cercare il manuale di istruzione di come si vive al meglio una giornata.
In questo senso, i programmi di formazione accademica in psicologia, che sto studiando con l’intenzione di completarli, al momento mi rendono perplesso.
Mi sembrano, per la precisione, molto orientati al fatto biologico più che a quello umano.
Orientati all’animale più che alla persona.
Orientati a guardare l’umano come se chi guarda non fosse umano, ma un tecnico che conosce bene gli altri umani.
Finora, naturalmente.
Sento il bisogno, continuando gli studi, di (re)incontrare l’umano di Carl Rogers, di Thomas Gordon, di James Bruner, di Jaques Lacan, di Carl Gustav Jung, di Sigmund Freud, di Sandor Ferenczy, di Jean Paul Sartre, di Eric Berne, di Aristotele, di Socrate, di Gustav Mahler, di Arnold Shoenberg, di Ryuichi Sakamoto, di George Simenon, di James Joyce, di Margaret Mead, di Anna Freud, di Melanie Klein, di Vincent Van Gogh e di tanti altri che hanno contribuito, insieme alla scienza, alla mia idea del mondo.
Chiedi info