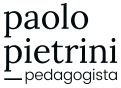A volte il linguaggio crea la realtà secondo un meccanismo tale per cui ciò che nominiamo prende forma concreta e inizia a esistere. Data per buona questa premessa, ne deriva che, se chiamiamo una cosa col nome sbagliato una, due, cento volte, alla fine questa cosa si chiamerà in modo diverso da prima, ovvero si trasformerà. Questo è un meccanismo che può essere virtuoso, quando produce, attraverso un miglior dettaglio, una comprensione più profonda delle cose; oppure vizioso, quando produce ad esempio una parola che ne contiene molte ma che viene usata senza questa consapevolezza riducendo molteplici significati a uno, costituendo così una potenziale fonte di equivoci.
Nel secondo caso, a mio avviso, è compresa la parola depressione.
Succede che nel linguaggio comune chiamiamo depressione la tristezza, la malinconia, lo scoraggiamento, la sensazione di non riuscire, la bassa autostima, l’umore basso e tanti altri sentimenti che proviamo, confondendo questa- che è una condizione molto complessa, stratificata, multifattoriale e che ha origini bio-psico-sociali – con alcuni dei suoi sintomi, anche quando ne vediamo uno solo.
Questo primo equivoco, in altre parole, nasce dall’uso comune del termine depressione per indicare sentimenti o situazioni di tipo depressivo, che ne possono indicare la presenza ma solo in concomitanza con altri e a certe condizioni di gravità e pervasività degli stessi. Da soli, non necessariamente la indicano.
Quando usiamo il termine depressione quello che frequentemente accade è l’attivazione contemporanea di due aspetti:
mentre lo si usa per indicare un generico malessere interiore, lo si pensa in riferimento alla sua precisa forma patologica. Così arriviamo al coincidere di due realtà che certo hanno una matrice comune ma che si differenziano tra loro e si esprimono in modo molto differente a seconda dell’intensità, della durata, delle circostanze, del momento storico di chi la vive.
Da ciò si genera il secondo equivoco, basato sulla presunta natura patologica di ciò che patologico non è; una delle conseguenze è la convinzione che solo certe figure professionali possano utilmente avere a che fare con quella che nel senso comune viene chiamata depressione, come sopra descritto. Se questo ha senso per le forme più gravi e complesse di depressione, non lo è per tutto il resto. La vicinanza di un vero amico può allontanare o lenire la tristezza, un buon insegnante può farci sentire capaci, un buon padre può sostenere un figlio e restituirgli fiducia e coraggio in un momento “no”. Dunque, una differenza va fatta.
Sintetizzando:
1 esiste una forma patologica di dolore psicologico che può assumere un carattere di gravità, pervasività e permanenza da determinare una condizione anche estrema che viene chiamata depressione che deve essere trattata da psichiatri, psicoterapeuti e psicologi.
2 esisono delle forme di disagio e sofferenza interiore più puntuali, circostanziate e meno pervasive che vengono comunemente chiamate o pensate nello stesso modo, le quali tuttavia non costituiscono una forma patologica – questo a causa di un linguaggio impoverito che finisce col farle coincidere con essa – e che possono essere affrontate e gestite, qualora incontrate, da figure differenti.
Chiariti questi aspetti, non voglio parlare qui di depressione patologica, materia di cui ho esperienza nella mia attività lavorativa, che tuttavia non mi compete in termini di trattazione e di trattamento. Mi riferirò dunque al resto, che in ogni caso è facilmente presente anche nelle situazioni patologiche, concentrandomi sul contributo di quelli che qui chiamerò sentimenti depressivi al superamento di certe situazioni di blocco.
Innanzitutto, la tendenza di oggi è quella di bandire ogni sentimento depressivo: vietato mostrare qualcosa di simile; ne consegue che per non essere banditi insieme a questi, li dobbiamo mascherare, nascondere arrivando anche a ignorarli.
L’inclusione nella socialità oggi passa in molti casi attraverso l’espressione “obbligatoria” di positività (come l’essere ottimisti o il pensare positivo), di forza, di energia, di performance in un mondo che promette possibilità illimitate a chi sa stare a quel passo. Il contrario rischia di farci sentire esclusi da tutto ciò e questo fa paura a tal punto da ignorare quello che dentro di noi non è così perfettamente positivo e carico di energia. Questo, tra l’altro, può spiegare almeno in parte la grande diffusione e aumento del consumo di sostanze attivanti, prima tra tutte la cocaina, i cui effetti allontanano temporaneamente quella paura. Il punto, naturalmente, non è che non vadano bene il pensiero positivo e l’ottimismo, anzi vanno benissimo a patto che siano espressione autentica di come ci sentiamo veramente e non un “cavallo di Troia” per farci accettare socialmente o per partecipare senza limite alcuno al banchetto delle infinite opportunità promesse. Anche qui, il punto non è che non sia giusto provare a farci accettare socialmente ma le strategie utilizzate devono essere coerenti con la nostra autentica natura se non vogiamo rischiare di interpretare un ruolo che alla lunga difficilmente riusciremo a reggere.
I sentimenti depressivi ci danno la possibilità di avere un contatto profondo con noi stessi, con tutte quelle parti di noi dimenticate, messe in ombra, difficili da affrontare, da sopportare che, tuttavia, fanno pur parte di noi, ci costituiscono insieme a tutte le altre. Trascurandone l’esistenza, potrebbero farsi sentire senza che noi, disabituati a “sentirle”, possiamo far altro che bloccarci, incapaci di gestirle. Passare del tempo laddove il sentimento depressivo ci conduce è forse uno dei modi più efficaci di scoprirci anche nelle nostre parti fragili, in quelle meno accettabili creando così la possibilità, riconoscendole come nostre, di ricostruirci, di restituire attenzione a ciò che è stato trascurato, di riprenderci importanti parti di noi, intrecciate in qualcosa che le zavorra sul fondo.
Le zavorre possono essere pregiudizi, convinzioni granitiche, idealizzazioni, ideologie imperanti, visioni distorte o imprecise della realtà a cui ci siamo affezionati per qualche motivo ma che, se capiamo essere causa di malessere, possiamo provare a cambiare con una vera e propra decisione.
Sentirsi “giù”, e la sofferenza che ne deriva, potrebbe indicare che siamo nel momento giusto per conoscerci meglio a patto di essere nelle condizioni di non dover fuggire da una sofferenza troppo intensa, fuga a cui sono spesso condannati i depressi patologici in modo disperato, inefficace e reiterato.
Si tratti di una o dell’altra forma di sofferenza, il comune denominatore affinchè chi soffre di depressione o di un sentimento depressivo possa ricevere qualcosa di utile per sè, risiede nelle competenze tecniche solo se integrate con quelle umane. Mostrare la speranza al disperato o la fiducia a chi l’ha persa è una competenza umana, non tecnica; una leva troppo spostata sul “sapere come”, che non attivi la competenza umana della vicinanza, può fare male anche se azionata da mani esperte.